La casa editrice “Europa Edizioni” ha pubblicato “Il Brigante e il Maestro”, un romanzo storico di Carmelo Conte che, dopo una lunga e fortunata stagione di politica attiva, ha dato spazio ai suoi ideali sviluppando con un’altra passione: scrivere di eventi politici storici, vissuti.
Perché il titolo “Il Brigante e il Maestro”?
Sono due figure emblematiche tra loro profondamente diverse che caratterizzano il libro. Giuseppe Tardio, il Brigante più noto della Campania, e Angelo Patri, il maestro, il pedagogista tra i più rinomati degli Stati uniti, li unisce solo il comune luogo di nascita, Piaggine, provincia di Salerno.
Perché ha scritto questo libro?
Lo devo a un evento imprevisto. Un pronipote della mia maestra di quinta elementare, la signora Irene Cinque, mi ha fatto avere gli originali di tre miei compiti in classe, fatti 75 anni fa circa, che egli aveva ricevuto in ricordo dalla nonna. Uno è sui “Moti del Cilento”, di cui fu protagonista, tra il 1861 e il 1863, il brigante Tardio; l’altro è una mia lettera al Giornalino di classe sulle bellezze naturali e i problemi sociali del Cilento; il terzo, intitolato “Una bravata”, racconta di un pugno dato da me, in classe, a un compagno e delle mie scuse pubbliche.
E’ un ‘autobiografia?
Non esattamente. Quei tre compiti hanno funzionato come le Madeleine, un dolce tipico francese, per Marcel Proust; che le ha dedicato alcune delle pagine più belle del suo libro “Alla ricerca del tempo perduto”, in cui spiega il processo della memoria involontaria. Sta a significare che, nella vita quotidiana, un odore, un sapore, un documento possono far rivivere in noi un ricordo non ricercato.
Quindi il protagonista del suo libro è il ricordo?
Un ricordo “non ricercato” ne è stata l’occasione. I protagonisti sono il brigantaggio, l’emigrazione, la scuola, il Cilento, la terra dei tristi, e Piaggine, un paese di montagna in cui sono nati sia il Brigante Tardio sia Angelo Patri: Piaggine. Allora contava circa 5 mila abitanti e ora, segno dei tempi, solo 1350.
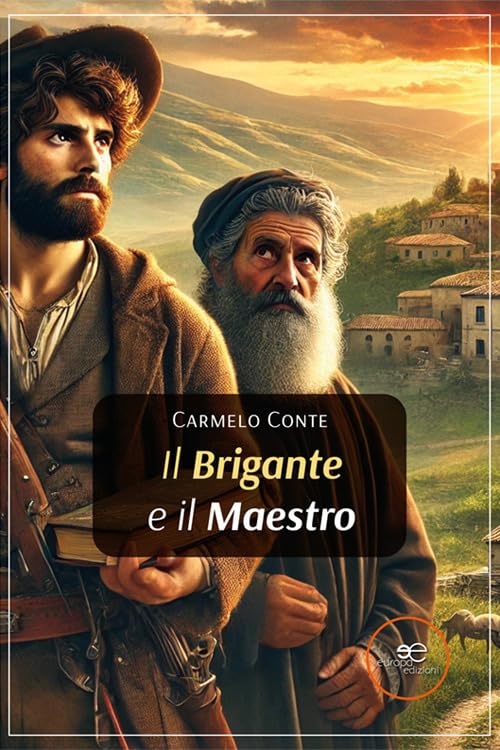
Cosa ha rappresentato il brigantaggio per il Mezzogiorno?
Pasquale Villari dedica le sue famose quattro lettere Meridionali rispettivamente a Mafia, Camorra, Brigantaggio e Rimedi. Condivido la sua analisi e la sua proposta, ma ritengo che il brigantaggio non possa essere assimilato a Mafia e Camorra.
Perché?
Innanzitutto va precisato che il brigantaggio è stato un fenomeno presente fin dall’antichità in molte parti del mondo e in molte regioni italiane, quindi non solo nel Mezzogiorno, anche se qui ha assunto caratteri particolari che lo collocano tra la leggenda, la storia, la ribellione e l’eversione. E’ stato un fenomeno in cui le spinte criminali si sono intrecciate e confuse con motivazioni sociali e politiche. Per segnalare queste diversità ho raccontato solo di due briganti, Angiolillo, un brigante sociale, un Robin Hood che toglieva ai ricchi e dava ai poveri, e Giuseppe Tardio, un brigante politico che, per combattere le sue battaglie contro i soprusi, deluso dal nuovo Stato, si schiera con i Borboni e promuovere la rivolta del Cilento.
Lei condivide i rimedi che furono adottati per contrastare e per combattere il brigantaggio?
Va innanzitutto precisato che, da un lato, i Borboni strumentalizzarono il brigantaggio, fino a farne una propria milizia. E, dall’altro, lo Stato unitario non lo considerò un fenomeno sociale da contrastare, come sostiene Riccardo Villari, con riforme strutturali, ma lo considerò un problema criminale e di ordine pubblico, perseguendolo con la legge Pica del 1963, che prevedeva la fucilazione e l’ergastolo, e con l’intervento dell’esercito. Tra il 1861 e il 1872 furono uccisi circa 270.000 meridionali, di cui meno di un terzo briganti, furono distrutti 51 paesi. In due comuni del Beneventano, Casalduni e Pontelandolfo, furono uccisi tutti gli uomini ivi residenti, furono risparmiati solo donne e bambini. Il governo del nuovo stato si comportò come Israele nella striscia di Gaza.
C’è un episodio che chiama direttamente in causa i Savoia?
Vale ricordarne uno in particolare. Giovanni Passannante, un anarchico, per avere tentato di colpire il Re, fu arrestato, processato e condannato all’ergastolo. Quando morì gli fu tagliata la testa e il cranio venne esposto nel museo del crimine, dove è restato fino al 2007. Il nome del suo comune di residenza fu cambiato da Salvia in Savoia di Lucania, in omaggio al Re.
L’emigrazione ha un rilievo principale nella sua ricostruzione storica?
L’emigrazione è stata ed è determinante per gli equilibri sociali. Esprime l’umanità in movimento e come tale va rispettata, indirizzata, guidata, condivisa, non criminalizzata. Nel mio libro ne tratto solo con riferimento allo specifico del Cilento nell’ottocento. Prima dell’unità d’Italia l’emigrazione era avversata dai Borboni perché non volevano che venissero meno le braccia per lavorare le terre dei latifondisti, mentre dopo i primi anni dell’Unità più che i singoli emigrava la vita delle famiglie, prima il padre che poi richiamava la moglie e i figli. Si emigrava per bisogno e nella speranza di una migliore. Gli emigrati subivano molte discriminazioni, famosa quella che si attribuisce a Richard Nixon che in un’intercettazione dice “gli italiani non sono come noi… non hanno lo stesso odore, non si riesce a trovarne uno che sia onesto”, è stato smentito dalla storia: in due secoli gli emigrati italiani sono diventati sei milioni, e alcuni di essi hanno raggiunto i vertici della società con incarichi e ruoli di grande prestigio, come Angelo Patri.
Quale rapporto ha intrattenuto Angelo Patri con l’Italia e con Piaggine, il suo paese di origine?
Il suo nome di origine era Angelo Petraglia, emigrò a cinque anni è fu registrato all’anagrafe del comune di New York come Angelo Patri, il suo cognome fu americanizzato da subito ed egli si è poi sentito americano più che italiano. La madre, Carmela Conte, era cugina di mio padre. Patri non ha mai dimenticato le sue origini, è stato più volte in Italia, ma mai a Piaggine, ha incontrato mio padre e un mio zio solo una volta a Paestum, nel 1927. Ha dedicato alle sue origini uno dei suoi libri più famosi, “Biondino l’emigrante”. Per ragioni di affinità ebbe rapporti intellettivi con i pedagogisti italiani più famosi, in particolare con Lombardi Radice, Maria Montessori, e con Don Milani.
Per questo lei dedica una lunga riflessione su Don Milani?
Ho ricordato Don Milani, nel contesto di una mia riflessione sulla conoscenza e la scuola, quella pubblica e quella privata. Don Milani ha rappresentato uno spartiacque che si racchiude nel valore distintivo tra le due sue opere fondamentali, Esperienze Pastorali dei suoi inizi e Lettera a una professoressa dei suoi ultimi anni a Barbiana, divenuta famosa in tutto il mondo.
Perché ha integrato il suo libro con una nota aggiuntiva, apparentemente estranea alla trama?
Credo che sia una naturale conclusione critica della tesi di fondo del libro: il rapporto tra storia e politica. Nota aggiuntiva è il titolo di un documento, scritto da Ugo La Malfa, con la collaborazione di Antonio Giolitti, Francesco Forte e Riccardo Lombardi. Segnò, nel 1962, l’avvio di grandi cambiamenti: la programmazione economica, la nazionalizzazione dell’energia elettrica, la riforma della scuola, l’integrazione territoriale e sociale. La richiamo in quanto antitesi alla Nota aggiuntiva del 2023 del governo Meloni. Il Premierato e l’autonomia differenziata che capovolgono quella impostazione, introducono due legature che personalizzano le istituzioni e dividono l’Italia. Propongono una questione settentrionale in alternativa a quella meridionale, negano la storia.




